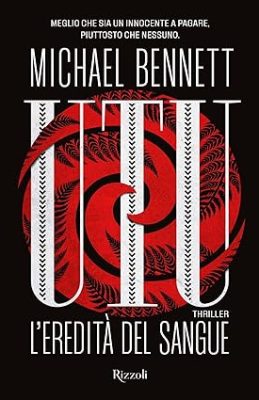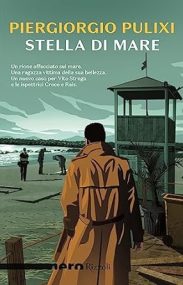UTU. L’eredità del sangue
Auckland, Nuova Zelanda, 1863. Sei soldati della corona britannica sono sotto un grande albero pūriri. Festeggiano la cattura e l’uccisione di un capo maori, nudo, mani e piedi bloccati: umiliato prima di essere impiccato. I tatuaggi sul volto e i segni incisi nella pelle indicano il suo lignaggio.
A ricordare l’avvenimento uno scatto fotografico.
Auckland, Nuova Zelanda, 2023. Centosessant’anni dopo. Hana Westerman, detective a capo di una squadra investigativa e donna tenace, riceve una mail anonima con un film amatoriale in allegato: una volta riconosciuto il luogo, gli agenti vi trovano un uomo impiccato, il primo di una lunga serie di delitti che inizia a insanguinare la città. Su ogni scena del crimine il killer lascia un koru, una spirale stilizzata simbolo di rinascita.
Le vittime sembrano scelte secondo uno schema preciso, che le collega in qualche modo al passato coloniale del paese e alle angherie subite dal popolo maori, all’arrivo delle forze armate britanniche, a metà Ottocento.
La vendetta è la forza trainante che conduce questa caccia all’uomo, il culmine dell’esasperazione di un popolo pacifico piegato e sottomesso alla corona britannica. Una forza che travolge anche Hana, colpevole di aver tradito le sue origini anni addietro.
Una caccia all’uomo che non perde un colpo e riporta in primo piano le ingiustizie di un passato troppo presto dimenticato.
RECENSIONE
Cammino all’indietro nel futuro con lo sguardo fisso sul passato
Proverbio maori.
UTU in maori, simboleggia “equilibrio e reciprocità”, sia in termini negativi che positivi.
Non ha un equivalente in inglese perché questo sentimento non è condiviso dai bianchi.
Un debito non svanisce col passare del tempo, ma quando l’equilibrio è completamente ristabilito.
La violenza genera violenza.
Gli omicidi del romanzo non sono da considerarsi “vendicativi”, ma UTU: l’assassino vuole ristabilire l’equilibrio spezzato quando, centosessant’anni prima, un importante capo maori è stato brutalmente ucciso da una compagnia di soldati britannici, venuti ad invadere la Nuova Zelanda.
UTU. L’eredità del sangue, si apre con un flashback nel passato.
Il lettore ancora non lo sa, ma questa istantanea spiega già molti quesiti.
Michael Bennet ci fa assaporare la cultura e le usanze maori, un’etnia colpita e martoriata dalla prepotenza e dall’arroganza della corona britannica.
Si sente forte il dolore di un popolo che è stato deprivato di tutto ciò a cui teneva e ha perso il suo equilibrio naturale. Persone che hanno valori e credenze così diverse dai bianchi che li hanno conquistati, da sentirsi svuotate della propria essenza, ora che sono costrette a vivere, invece, secondo i loro dogmi.
Dai tempi di Pompei, Auckland è la prima città costruita su un terreno vulcanico attivo, incredibilmente fertile. Terreni che sono stati strappati ai nativi, i quali hanno sempre visto la terra non come una proprietà esclusiva, ma come elemento di condivisione.
L’autore ci restituisce la verità maori non solo attraverso la storia che racconta, ma anche introducendo la loro lingua all’interno del romanzo. Non mancano, infatti, i dialoghi o i pensieri in te reo.
In questa cultura, i tatuaggi sono come il DNA, raccontano il lignaggio e la provenienza di ogni individuo. Nel romanzo hanno un ruolo molto importante.
L’assassino, maori, combatte da sempre battaglie a nome del suo popolo, cercando di instillare nei giovani un senso di ribellione o quantomeno di non accettazione di quel destino che li vede come eterni perdenti.
L’uomo, relativamente giovane e profondamente erudito, rivendica le vessazioni subite dal suo popolo,
che accetta tutto come agnellini
Si intuisce che le donne maori sono molto forti, determinate e sicure, normalmente a capo delle loro comunità.
Un altro tema trattato, anche se comunque in secondo piano rispetto alla storia, è quello LGBTQ+, attraverso Addison, la figlia di Hana e Jaye (ex marito della donna e capo della polizia).
La ragazza, infatti, è una testa calda (e rasata), contro il sistema, la classica adolescente che contrasta i suoi soprattutto perché sono poliziotti, anche se ha gran rispetto, amore sconfinato e timore per la madre più che per il padre, con il quale, però, ha una complicità invidiabile. Attraverso i suoi concerti rap, si fa portatrice di valori importanti, soprattutto tra i giovani. Gioca un ruolo fondamentale nella vicenda.
Scoprire la terribile macchia nel passato di sua madre la distrugge, non se ne capacita: Hana Westerman è colpevole di aver tradito la sua gente, per seguire la legge dei bianchi. Sul monte Suffolk, luogo sacro, scenario di ingiustizie e spargimento di sangue sin dell’Ottocento, diciott’anni prima (quando Addison era appena un fagiolino nella pancia), i manifestanti che reclamavano la loro terra e la loro cultura venivano malmenati e repressi da agenti di polizia della loro stessa stirpe, quelli mandati in prima linea sin dai tempi della seconda grande guerra dalla corona britannica, le pedine sacrificabili per i bianchi.
Hana e i suoi colleghi, loro malgrado, eseguivano gli ordini.
Questo è anche il conflitto maggiore della protagonista, quello che anni prima l’ha allontanata da Jaye, l’amore della sua vita.
La domanda di sottofondo del romanzo è delicata e profonda: è giusto seguire i dettami e le leggi dei conquistatori che hanno sottomesso un popolo in pace e armonia con la terra? Oppure bisogna rivendicare i valori e i diritti di quel popolo? Dove sta veramente la giustizia?
È giusto rinnegare se stessi, la propria gente, il proprio sistema di valori per eseguire degli ordini? Per non perdere il posto di lavoro? Perché si è gli ultimi arrivati?
La protagonista è tormentata da un conflitto interiore: essere fedele alla sua gente, alle sue usanze, alla spiritualità del luogo o ai pākehā, coloro che li hanno brutalmente colonizzati.
Inevitabilmente, siamo contagiati da queste domande che devono trovare risposta e viene quasi logico empatizzare e simpatizzare per l’assassino, che in fondo non fa altro che riportare luce laddove, negli ultimi duecento anni, sono calate le tenebre.
Lo stile di quest’autore non mi fa innamorare del romanzo, la scrittura a mio parere è quasi un po’ cruda.
L’incipit sembra partire un po’ a fatica, il romanzo comincia a farsi interessante, anche dal punto di vista stilistico, solo più avanti. Come se l’autore avesse avuto bisogno di riscaldarsi.
Accurata l’introspezione della protagonista, che porta il peso della sua etnia e della scelta di stare con un bianco.
Ho apprezzato la simbologia della luce verdognola che fa sembrare gli ex coniugi malaticci, rispecchiando il loro stato d’animo.
Molto bello anche il contrasto tra le forme arrotondate dalla gravidanza e la lingua tagliente della cugina di Hana.
Bennett è bravo a creare momenti di suspense, in crescendo, alternando sequenze narrative a quelle riflessive. Specialmente alla fine, ho vissuto veri attimi di panico e non vedevo l’ora di sapere che cosa sarebbe successo, perché il finale non è per nulla scontato. Tutto può essere.
Le informazioni, ben dosate, creano il giusto grado di curiosità nel lettore.
Tuttavia, i dialoghi a volte mi sembrano scialbi, un po’ banali.
Capita che l’autore si focalizzi su dettagli, per dare spessore al testo, che però risultano insignificanti e poco funzionali al momento. Come, ad esempio, il fatto di toccare i guanti in lattice che somigliano a un palloncino scoppiato e constatare che non sia una sensazione piacevole mentre Hana riflette sull’accusa ricevuta da un maledetto stupratore. Dettaglio, in quel momento, fuori luogo.
Il narratore è alla terza persona, con punto di vista mobile e cambia all’occorrenza, passando dal soldato a inizio storia, alla detective Westerman, alla figlia Addison, all’assassino e a volte segue anche le vittime.
In più di un’occasione il patto finzionale è venuto meno, c’è stata un’ingerenza di POV, a mio avviso. Ad esempio, a un certo punto, mentre l’attenzione era sull’assassino, di colpo il focus passa sulla protagonista per un attimo e questo è totalmente fuori luogo sia per un discorso strutturale che proprio di credibilità. Il punto di vista mobile richiede estrema precisione ed equilibrio.
Questo è il primo romanzo di Michael Bennett, nonostante sia un noto sceneggiatore neozelandese. Alcuni luoghi, così come i nomi, sono stati inventati.
In generale, mi sento di dire che è una buona penna, la struttura del romanzo è imbastita secondo i giusti canoni, ma a volte cade in certe banalità, frasi ridondanti e ritrite.
Traduzione: Annamaria Raffo
Editore: Rizzoli
Pagine: 300
Anno pubblicazione: 2023
AUTORE
Michael Bennett è uno sceneggiatore, autore e regista neozelandese. Con i suoi film ha partecipato ai più importanti festival cinematografici internazionali, da Cannes a Berlino a New York. “UTU. L’eredità del sangue” è il suo primo romanzo.